Recensione a "La Torre del Maestr" (2004) di Hand Ulrich Treichel.
15 MAGGIO 2005-05-15
Hans-Ulrich Treichel, La torre del maestro, ed. orig. 2000, trad. dal ted. di Silvia Bortoli, Einaudi, Milano 2004, pp.153, Euro 14,00 ISBN88-06-16356-6
Treichel, classe 1952, nasce come poeta lirico (Ein Restposten Zukunft. Gedichte, 1979; Tarantella, 1982; Liebe Not. Gedichte, 1986), ma diventa romanziere appena avverte che la vena poetica sta sfociando in quella prosastica. Ponte tra queste due forme sono i libretti d’opera per Hans Werner Henze (Das verratene Meer, 1990; Venus und Adonis, 1997). Del resto i due generi interagiscono, avendo le sue poesie tratti narrativi, e così la sua prosa dei connotati poetici, che dalla scrittura in versi ereditano l’impostazione antieroica ed autoironica.
Già nel primo romanzo autobiografico, Der Verlorene (Il fratello perduto, L’Indice,…...), l’attenzione al tempo storico, privato e collettivo, al territorio, conosciuto o da esplorare, all’ “altro da sé” posto a distanza, esaminato analiticamente, temuto e insieme desiderato, si accosta ad un’impietosa autoanalisi. Vi domina, inoltre, un senso di “smarrimento”, che, oltre ad essere psicologico ed esistenziale, è epocale. La torre del Maestro ne ripropone il senso di perdita e spaesamento, ma addizionandolo di un’idea del viaggio come percorso formativo tra paesaggi, classi sociali, saperi, generi e linguaggi diversi. Un nuovo dato che caratterizza questo romanzo del 2000 è l’intertestualità e interculturalità: vi s’intrecciano l’ambiente intellettuale ed artistico europeo con una puntata caricaturale del protagonista, Georg Zimmer, negli gli Stati Uniti – dove si sente più che mai straniero agli altri e a se stesso – fino alla villa siciliana del Maestro, che in quella residenza si accinge a comporre la sua nuova opera, gli Elysian Fields.
Il romanzo si apre con una suggestiva descrizione paesaggistica in immediata collisione con la comparsa di due grosse macchine a motore, un emblematico traghetto e un’alta cilindrata Bentley. Giunto in Scozia, Georg approda sulla prima delle due isole del romanzo (l’altra è la Sicilia), atteso dal suo enigmatico “ospite”, Bergmann, ricco compositore di fama internazionale che, dotato com’è di talento e benessere, ha un effetto paralizzante e al contempo euforizzante sul provinciale Georg. Nell’avvicendarsi dei molti avvenimenti, pensieri e alternanti umori che contribuiscono a creare il forte contrasto tra queste due personalità, e dinanzi al simbolismo della “Torre”, che colloca immediatamente Georg in posizione di soggezione rispetto a Bergmann, maestro di “vecchiaia”, “bellezza” ed “utopia”, l’ironia rappresenta per il protagonista un filtro difensivo, l’antidoto che Treichel impiega per contestualizzarne un’angoscia che è generazionale, nonché di classe: “Essere disperati era appannaggio della gioventù” (p. 130)
L’acume introspettivo con cui il narratore onnisciente presenta Georg, giovane scrittore d’estrazione piccolo borghese in tacita polemica con se stesso e con il suo talento, conferisce spessore psicologico alle sue esagerate risposte emotive all’ambiente e al mondo prestigioso del compositore Bergmann, e chiarisce al contempo i procedimenti di una tecnica narrativa che attraverso il “viaggio” nel mondo della musica ripercorre per analogia l’esplorazione che Georg fa delle varie modalità di scrittura con cui si trova ad entrare in contatto. Dottorando che faticosamente elabora una tesi dal titolo L'oblio in letteratura, Georg studia implicitamente un proprio stile, da collocarsi tra la cosciente ricerca proustiana della memoria perduta e i meccanismi inconsci che risiedono alla base dei fenomeni del “rimosso”, allegorizzato col continuo richiamo al fiume Lete: “Non voleva dimostrare soltanto che l’autore dimentica quanto ha scritto. Voleva dimostrare anche che quanto si è scritto viene scritto solo per essere dimenticato” (p. 9)
Per Georg, l’incontro con Bergmann, che lo ha ingaggiato perché lo aiuti a riscrivere la propria autobiografia, da una parte rappresenta l’occasione propizia della sua vita professionale, e dall’altra la possibilità di un confronto più diretto e autentico con l’Altro. L’esperienza, nel suo insieme, acutizza in Georg il senso dei propri limiti, facendo riaffiorare sentimenti di colpa, inadeguatezza e vergogna, come accade a New York, dinanzi al conto che gli viene presentato ad un ristorante di Central Park: “Si odiava per quel logorio dei nervi gastrici che a loro volta gli logoravano l’anima” (p. 81). La narrazione della magnifica vita di Bergmann, riscritta da Georg, riconferma inoltre il mito del grande compositore tedesco, Henze, a cui il personaggio del romanzo si ispira, rappresentandolo legittimamente in una Torre d’avorio, la quale offre la misura della scala di valori che lo sanciscono Maestro. Sul piano dell’autobiografismo obliquo, la figura di Bergmann diventa dunque il modello con cui Treichel dovrà misurarsi e a cui dovrà adeguarsi, quale futuro librettista di Henze. Il difficile confronto sfocerà in un patto narrativo tra il genio affermato e lo scrittore emergente. La richiesta fattagli da Bergmann di scrivere per gli Elysian Fields un inno “bello e ammaliante”, sul modello della poesia di Hölderlin, ma modernizzato, è una sfida ardua e Georg è colto dall’atroce dubbio di non essere all’altezza del compito affidatogli: per noi, il rimando è ad un confessionalismo di tipo sveviano, informato del pessimismo e dell’ironia dell’intelligenza.
Erminia Passannanti (PhD, UCL), Docente, erminia.passannanti@talk21.com
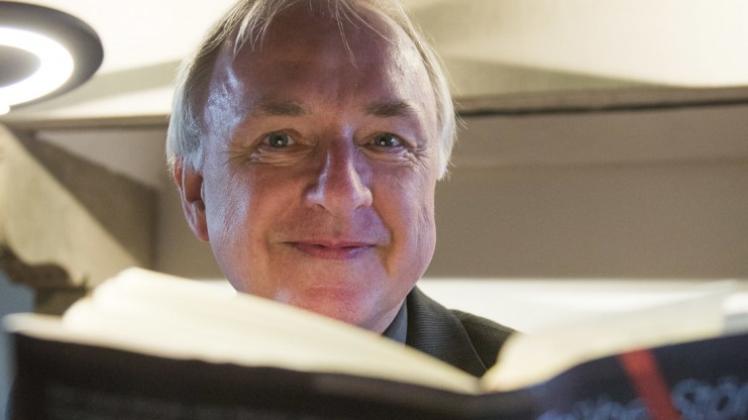


Commenti
Posta un commento
Postate qui i vostri commenti, per favore. O scrivete a erminia.passannanti@talk21.com Grazie.